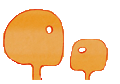Ommammamia … io non so se sono costruttivista. Il problema è che ogni volta che sento qualcuno dire "Quel collega è comportamentista o quell'altro collega è connessionista ecc." mi viene sempre in mente quando vanno a casa, e stanno coi figli, oppure vanno in vacanza … Come vanno in vacanza da comportamentisti?, come si va in vacanza da ermeneutici o da connessionisti? Io non lo so …forse mi da fastidio quando di me dicono "è costruttivista" o "è fenomenologa", perché per me il costruttivismo è un paradigma, un modo di lavorare, mentre la fenomenologia è un modo di guardare le cose, ed entrambi sono adatti a me. Dire "io sono costruttivista" mi sembra equivalente a negare questo modo di lavorare perché vuol dire non lasciarsi la possibilità di altri sguardi. Allora, se la domanda è se lavoro meglio col costruttivismo più che con altri impianti teorici, rispondo di sì, che è più adatto a me, dato che questo orientamento ha ben presente l'enorme e visibilissima limitatezza della conoscenza.
È umile…
È umile, ma non in senso negativo. La parola umile ha assunto purtroppo nel linguaggio corrente un significato negativo. Umile, invece, vuol dire partire dal basso, avere presente l'angolazione prospettica della conoscenza, e quindi un paradigma umile è forse più avventuroso, più coraggioso. Umile non vuol dire "che sta al suo posto", o che non può andare in alto. Vuol dire invece ricerca, possibilità di allargare gli orizzonti "a partire da qui", da ciò che mi è "alla mano".
Il fatto che fare costruttivismo ha significato stare all'opposizione, e non al potere ha significato qualcosa nella scelta?
E' vero. Appoggio sempre la minoranza, ma non per principio. Mi trovo tra le minoranze per lo stesso motivo che ho appena detto: perché di solito il potere è arrogante. Il potere sa di aver ragione e quindi sa che sta dalla parte giusta ed ha capito come vanno le cose. Sa "come si fa" e per questo ha quel sorrisetto alla Piero Angela, di chi sa e magari, benignamente, diffonde tra gli altri la sua sapienza, la concede. Oppure tiene nascosto il suo sapere per continuare a guardare gli altri con sufficienza. Quando anche i costruttivisti diventassero così (e già segnali ce ne sono) a me verrebbe voglia di fare qualche altra cosa. Non per essere il bastian contrario, o per una presa di posizione, per principio. Solo perché non potrei riconoscermi più. All'inizio scegli una strada perché sei in un certo modo, o meglio non "sei" ma "guardi le cose in un certo modo", però quando qualche persona decide che quella è la strada giusta e comincia ad imporla ad altri (questo è il paradigma vincente, quello che viene presentato come il migliore) allora, anche se l'idea iniziale era buona, viene tradita dall'atteggiamento con cui è usata. Io, come dicevo, ho colto, anche tra i costruttivisti, qualche indizio di questo atteggiamento da "chi è il più costruttivista del reame?", che critica chi non ha "veramente capito" come si deve pensare e lavorare.
Questo atteggiamento è già contaminato dal dogmatismo, dall'ideologia, dall'arroganza di chi sta "dalla parte giusta", rispetto "a quei cretini di oggettivisti". E non c'è niente di più contradditorio per uno che si dichiara costruttivista. Quando dico che il costruttivismo mi è congeniale, non posso affermare contemporaneamente che ha sicuramente ragione. Per fare un esempio: ho letto da poco un libro bellissimo, un dialogo tra Ricoeur e Changeux: tu sai che sarei dovuta stare dalla parte di Ricoeur; a me veniva voglia, invece, di stare dalla parte di Changeux, che è un neurobiologo (e giuro che era del tutto spontaneo). Perché? Perché quello che diceva Ricoeur per me era scontato, quindi provavo a mettermi dall'altra parte perché anche le altre ragioni mi sembravano plausibili e interessanti e poi perché è divertente. E' un gioco cambiare prospettiva! In questo senso mi piace il costruttivismo: perché, secondo me, significa questo: provare a mettersi nei panni di qualcun altro, vedere le cose da un altro punto di vista, cambiare il punto di osservazione.
Lei ha scritto "la persona sembra essere una forma in movimento che ha paura di cambiare" Io mi domando allora come si può sopportare il cambiamento, come si può vedere nel cambiamento non più una sofferenza, ma una necessità umana?
Questo, secondo me, è un argomento veramente serio. Mi ricordo quando ho scritto questa cosa; ero in un periodo polemico con i costruttivisti, perché mi sembrava che si limitassero ad "applicare" le regole di Kelly, o meglio che applicassero i principi del costruttivismo come fossero regole. Si stava ripetendo lo stesso modo di fare degli oggettivisti e dei realisti ingenui: prendere una teoria e metterla in pratica; ciò vuol dire non pensare più, non confrontarsi più con l'esperienza reale, effettiva, con le cose che si incontrano, ma leggerle subito con le categorie già pronte, in questo caso con le idee di Kelly.
In quel periodo, almeno nelle cose che leggevo, emergeva una sorta di enfasi del cambiamento (la volontà di produrre un cambiamento a tutti i costi) che mi disturbava. Tornavo alla mia esperienza personale, a quella delle persone che conosco, alla vita insomma …alla vita come è veramente vissuta, e mi accorgevo che non era così scontata questa enfasi del cambiamento, come non era scontata, secondo me, la dicotomia dei costrutti su cui si basava questa spinta a cambiare le persone. Insomma, c'erano delle cose che, dal mio punto di vista, andavano messe in discussione. Sono tornata a leggere Kelly, in quel periodo, e nei suoi testi ritornavano spesso affermazioni di questo genere: "Io spero che questa mia teoria sia messa in discussione…molte cose dovranno essere riviste…spero che i miei allievi, quelli che verranno dopo di me, sperimentino nuove strade…ecc." Ecco, questo non era successo! Di solito viene preso per buono quello che Kelly ha detto e si cerca soltanto di applicarlo.
Io credo che Kelly sia un grande psicologo, perché, se non altro, come gli hanno riconosciuto in molti (tra cui Bruner in una antica recensione), è riuscito a creare una teoria autoreferenziale, una teoria psicologica che è anche una teoria della conoscenza, senza contraddizioni. E' un lavoro importante il suo perché ha costruito una teoria rigorosa, formalizzata e, insieme, aperta al nuovo; ma, appunto, in questo lavoro era implicita la critica e l'voluzione; ed invece, se guardi la letteratura in ambito kelliano, è una sorta di agiografia…
Ma fosse solo un problema di letteratura…perché quando scrivo un articolo ho un potere che è limitato, ma quando faccio terapia ho una responsabilità enorme perché sono in relazione ed influenzo un'altra vita in maniera più che diretta. Per cui parlare di cambiamento senza porsi il problema di cosa sia e come possa essere sopportato forse è ancora più arrogante…
Kelly aveva previsto la minaccia di colpa, la minaccia che è insita nel cambiamento. Per questo c'è una "sana ambiguità" nel discorso di Kelly. "Sana", sì, perché è l'esperienza umana ad essere ambigua. Una persona si annoia ed allo stesso tempo ha paura di cambiare ambiente. Si continua spesso a vivere in una situazione che ci dà sicurezza, anche se non ci soddisfa più. Si tratta di un'ambiguità esistenziale, che possiamo sperimentare tutti. Per questo è assurdo continuare a servirci unicamente di categorie logiche, quando analizziamo l'esistenza, specialmente in riferimento a Kelly, che, invece, è stato l'unico a deviare un po' il corso dello sguardo sui fenomeni psicologici (almeno tra gli psicologi americani). Ripetere lo stesso modo di fare psicologia degli approcci teorici precedenti, che Kelly criticava, è secondo me lo sbaglio più grosso e il più grosso tradimento che si possa fare al costruttivismo.
Non si può invocare il cambiamento degli altri, se non siamo noi stessi insofferenti della ripetizione. Personalmente, quando gli studenti mi chiedono una tesi sulle griglie di repertorio, mi viene da scappare via. Non ne posso più di fare tesi con le griglie.
Ce n'è proprio uno qua fuori!
Ce ne sono tanti di studenti qua fuori… e mi fa ancora più paura che molti di loro, che sono giovani, non fanno che chiederti istruzioni su come si usano le griglie, senza rischiare un'idea, un'invenzione …e poi tu mi chiedevi perché sto con le minoranze! Sto all'opposizione perché la maggior parte della gente che io frequento non ha fantasia e la fantasia è l'unico pregio che ho! Mi trovo male in mezzo a gente che non ha fantasia. Naturalmente ci sono studenti diversi e con quelli lavoro molto bene, anche divertendomi.
Visto che la filosofia costruttivista è una delle possibili visioni del mondo, coloro che come lei scelgono tale approccio che ruolo gli danno all'interno della propria vita privata?
Vedi? Tu avevi preparato questa domanda, ma già alla prima mi è venuto in mente di risponderti, non so perché, pensando a come un costruttivista si differenzia da un comportamentista nella sua vita privata. Io credo che dovrebbe esserci un legame tra quello che una persona pensa nel suo lavoro di ricerca, nella sua professione, nelle teorie che abbraccia, ed il suo modo di vivere. Purtroppo, però, questo è piuttosto raro, perché succede che, per una serie di circostanze storiche, o per mancanza di fantasia, uno abbraccia la teoria che si trova di fronte, che è del suo maestro, dell'accademia in cui lavora, della scuola che ha fatto per caso. Ci sono anche i costruttivisti per caso! E se è così, fanno un po' ridere questi "ismi" attaccati alle persone, perché, ovviamente, la vita è molto di più di questo. Ho visto certi fenomenologi predicare il rispetto dell'alterità ed essere cattivissimi con moglie e figli; di queste contraddizioni ne vedo continuamente, e probabilmente le vivo anch'io in prima persona. Ma qui ritorna il tema dell'ambiguità ineliminabile…Ognuno fa i conti con se stesso.
E vero, però, che la mia domanda sulla vita quotidiana può essermi venuta in mente perché, in qualche modo, l'"ismo" del costruttivismo mi ha cambiato la vita. In questo lavoro di psicologo devi frenare spesso la tua fantasia. Se non avessi trovato un costruttivismo che mi diceva "guarda che se non usi la fantasia non fai ricerca" forse mi sarei trovata in difficoltà.
Non so se mi illudo, ma anch'io credo di riconoscermi nel costruttivismo per la sua apertura alla novità, e anche in questo senso ci viene spontanea la domanda sulla vita privata: di solito, mi capita di provare più stima e simpatia per le persone che scelgono il costruttivismo, perché lavoro meglio insieme a loro, ho delle relazioni migliori con queste persone.
Ecco: ti aggiungo una citazione perché tu possa scriverla sulla tua intervista; è bellissima, secondo me. Merleau-Ponty, quando parla della fenomenologia, che tu sai mi sta persino un po' più a cuore del costruttivismo, dice che "non si può entrare nella fenomenologia se non attraverso un metodo fenomenologico". È un circolo, una spirale. Io penso che tu abbia trovato interessante il costruttivismo, perché eri già "costruttivista", altrimenti non lo avresti trovato interessante. Ma esistono anche persone che sanno che va di moda il costruttivismo ed allora cominciano ad interessarsi, a leggere, mi chiedono la bibliografia. Vogliono diventare costruttivisti, perché adesso bisogna sapere cos'è questo costruttivismo, ed aggiungono questa parola in fondo ai loro titoli precedenti, tipo: "sistemico-costruttivista", "cognitivo-costruttivista". Insomma, si sentono costretti a rimanere sull'onda del progresso e guardano al costruttivismo, ma lo leggono inevitabilmente secondo categorie che non sono coerenti con esso, semplicemente perché non hanno quello sguardo, non hanno già, naturalmente, quel metodo.
Così avviene anche tra gli studenti: alcuni vedi che spalancano gli occhi quando dici una certa cosa, perché nessuno gliel'aveva mai detta, ma non stavano aspettando altro. Era già così che sentivano e quindi hanno trovato un nome ad un loro modo spontaneo di guardare. Ce ne sono altri, invece, che imparano tutto, sono bravissimi, e non riesci neanche a bocciarli perché sanno a memoria tutte le transizioni di Kelly e le tecniche dell'autocaratterizzazione, però non avranno mai un atteggiamento costruttivista.
Per esempio, oggi a lezione dicevo qualcosa come:- "E' più importante capire come una persona vive il suo mondo, come vive quell'evento, che sapere se è vero o meno che i suoi familiari le hanno fatto quel certo torto; o, perlomeno, non è più importante sapere la verità che comprendere i significati". Ma alcuni degli studenti volevano a tutti costi scoprire la "verità", volevano sapere se quella persona era "veramente" una vittima… Non entrava nel loro sistema l'idea che non possiamo fare i detective, che non è nei nostri doveri l'accertamento dei fatti, peraltro, dal nostro punto di vista, impossibile. Come fai ad accertare se una persona è una vittima, quando la parola "vittima" è, appunto, una parola che può assumere significati personali indefiniti? Dato per scontato che quella persona non è segregata e picchiata tutti i giorni, o maltrattata evidentemente, chi può decidere se il suo "costruirsi" ugualmente come vittima nei rapporti familiari, è giusto o sbagliato? Questo a me appare con tutta chiarezza; a quegli studenti, invece, che magari sanno tutti i corollari della teoria a memoria, non appare.
Riassumendo: secondo me ha ragione Merleau Ponty; o sei già fenomenologo o non capirai mai la fenomenologia, o hai già uno sguardo orientato verso i significati o non capirai mai il costruttivismo, o hai già questo senso profondo del limite della conoscenza e del limite di ogni ricerca, o devi scegliere un'altra strada.
L'altra domanda che le volevo fare era relativa alla didattica, visto che io lei la vivo come la mia insegnante: come si esprime nel suo modo di fare didattica l'essere un costruttivista? Secondo me lei è a tutto tondo un insegnante, può scrivere tutti i libri che vuole ma rimane un'insegnante.
Hai ragione. Infatti mi diverto di più quando faccio lezione che quando scrivo. E' una questione di rapporto, di relazione, di essere insieme agli altri, che per me è vitale. Quando scrivo qualcosa, poi non lo voglio più vedere. Penso che l'umanità, senza le cose che scrivo, vivrà benissimo lo stesso. Qualche volta, invece, ho la sensazione di una "realizzazione" quando i miei studenti mi scrivono, mi dicono che ora lavorano e che le cose che hanno imparato da me sono utili al loro lavoro. Questa cosa è un po' da vecchia professoressa, ma io sono una vecchia professoressa e sono contenta quando ho questa percezione, o illusione, di essere servita a qualcosa, a qualcuno, per esempio di aver fatto incontrare delle persone come voi, che si trovano bene insieme. Questo mi da spontaneamente un senso di piacere.
Sennò finisce che uno vive per quello che ha scritto. Questa marea di libri polverosi che si trovano dappertutto… Ogni giorno qualcuno mi regala un suo libro ed io non ho tempo di leggerlo…anche se poi lo faccio. Del mio professore, che amavo tanto, come un padre, io ricordo le sue frasi, i suoi sguardi, le sue parole, ed i suoi libri non li leggo più.
Bella questa cosa, la condivido tanto. Con Giliberto, una volta, abbiamo parlato di questo. Lui mi ha chiesto il motivo per cui mi sono appassionata al costruttivismo. Ed io gli ho risposto:-"Guarda che non mi sono mica appassionata al costruttivismo, mi sono appassionata alla relazione che ho stabilito con l'Armezzani, perché secondo me prima dei concetti passano le relazioni e vedere lei che parlava a lezione e veramente credeva in quelle cose che diceva e poi vedere che era così umana ha fatto scattare in me qualcosa".
Questa è una dimensione in cui ci si riconosce subito tra persone, non c'è bisogno di "ismi". Ci si riconosce perché se non fosse esistito Von Glasersfeld o Kelly o Maturana e Varela ci saremmo capiti lo stesso, chiamandola in altro modo questa dimensione. Se fossimo vissuti ai tempi di Socrate l'avremmo chiamata ironia. Io non ho mai posto le cose che mi riguardano come un aver ragione o torto, però è essenziale il riconoscimento, il trovarsi non soli nel guardare in un certo modo. E' molto importante …
Questa è una domanda a cui tengo: ho letto di recente il libro di Alda Merini "La vita facile" e c'è una frase che mi ha colpito "Sai perché sei il mio vestito di carta perché sei come una grande camicia di lana, una camicia di forza. Sei la mia follia e tu non sai quanto la follia sia fatta di sola carta". Le va di commentarla?
La Merini mi spaventa, io l'ho letta e mi spaventa, perché è la rappresentazione vivente dei limiti labili tra quello che si chiama follia e quello che non si chiama così. Io divido l'umanità, con le mie categorie mentali assolutamente autistiche, in "matti buoni" e "matti cattivi" e la Merini è una matta buona, cioè una che ha il coraggio di guardare, e, secondo me, quando uno guarda veramente, quando ha questo coraggio, rischia grosso. La Merini mi spaventa perché è una allusione a questo rischio. Anche se la sua poesia è folgorante, qualche volta mi trattengo dal leggerla perché mi trattengo dal desiderio di guardare…è un rischio grosso.
Io non escludo che si possa essere matti anche a causa di una lesione organica , però so che quando una persona va nel profondo, quando ha questo coraggio, quando non si rifugia dietro ai ripari (anche delle teorie dei costruttivismi), quando ha questo tarlo della trascendanza, del guardare oltre, il rischio è appunto di "andare oltre" proprio…
Però la follia è anche fatta di carta e questo mi tranquillizza perché mi sembra che la possa strappare quando vuole.
Si, forse si può sempre tornare indietro, però la paura a me non viene dal guardare oltre. Se non le capacità, il coraggio ce l'avrei… (…Dostoevskij, più di tutti, ce l'ha fatto capire che non si può essere così grandi senza essere "matti", ma appunto bisogna essere grandi).
Quello che spaventa è il bisogno di ancoraggio con gli altri, con le responsabilità quotidiane. Non mi posso permettere di diventare matta, perché ho una figlia che ne soffrirebbe, altrimenti, forse, un viaggetto me lo farei …Questi sono gli ancoraggi della vita. E cerco sempre di tenermeli stretti, anche se posso capire l'altra dimensione. Per esempio avevo le vertigini leggendo Dotoevskij; qualche volta andavo avanti a leggere tutta la notte; altre volte, invece, se ero troppo disposta verso questa dimensione-limite, chiudevo il libro, perché mi ricordavo che il giorno dopo dovevo… che ne so… accompagnare mia figlia a scuola o terminare un lavoro.
Ecco: questa è l'ambiguità. È proprio come nelle figure geometriche dei gestaltisti: le puoi guardare come una cosa o come un'altra, ma sono sempre la stessa figura e in questa dimensione labile io vivo spesso. Il guaio della vita sarebbe chiudersi dietro una della facce del diedro: o essere una di quelle persone banali che vivono solo del quotidiano, pensando solo alla prossima relazione al convegno, preoccupandosi di avere tutte le cose a posto, ricordandosi di telefonare alla persona giusta…D'altra parte, non si può neanche essere come quelli che cercano solo l'altra dimensione, perché allora perdi i contatti con la vita autentica, perché, alla fine, non ti segue nessuno e allora non soltanto sei solo, ma non ha più senso che tu viva queste esperienze, se non le puoi comunicare, se non puoi farle diventare vita corrente … Si, c'è anche la difficoltà, quando si rimane così presi dai nostri ancoraggi, che, proprio per questo, non ci sia comunicazione, non ci sia più residuo dell'altra parte, quella più "folle", più creativa.
Il difficile è conservare un equilibrio instabile…instabile sì, e, quindi, mettere in conto che qualche momento di caduta nell'una o nell'altra dimensione lo dobbiamo vivere. Ma, in fondo, il bello della vita è questa ambiguità, questo possibile cambiare di piani e di sensazioni: così mentre guardi un film, banalmente, in una sera qualunque, qualcosa ti richiama l'altra parte e puoi andarci dentro, poi riuscirne…ma puoi sempre rientrare alla prossima occasione e, insomma, vivere questa vita che ha dei momenti esaltanti e dei momenti banali. L'importante è non perdere di vista che esiste l'altra dimensione: quella della vita corrente, che non vuol dire per forza "banale", ma vuol dire impegni, responsabilità, vuol dire condivisione, costruzione di cose concrete… E nello stesso tempo non perdere l'apertura continua all'altra parte…
Si fatica, però …e resta il rischio della solitudine, perché tra "matti" ci si riconosce, tra persone "ancorate" ci si riconosce, ma quando si è nella terra di mezzo è più difficile incontrare viandanti…anche se la terra di mezzo è la vita! ( e se la ride). Quest'intervista è degenerata! È degenerata, si! Parliamo di costruttivismo.
L'ultima domanda riguarda la dimensione della creatività: F. R . Epting afferma che uno dei "doveri" del terapeuta costruttivista "consiste nell'esprimere le sue migliori qualità umane affinchè il cliente le possa utilizzare". Il terapeuta, insomma "dovrebbe essere creativo nel suo approccio con il cliente". Facendo riferimento alla sua esperienza come si manifesta ed in cosa consiste la creatività del terapeuta costruttivista?
All'Università dove lavora Epting c'è attualmente un mio laureato, e mi scrive che Epting passa molto tempo con gli studenti, che parla con loro di tutto, anche di questioni personali, di vita, e lui è sempre pronto ad ascoltare. Intanto c'è questo aspetto di disponibilità. La parola "disponibilità", io la odio: me la prendo quando qualche studente me l'attribuisce perché viene usata come equivalente di "mite" o "pronto per l'uso"; ma qui la intendo come "capacità di interesse" per l'altro. La creatività nasce proprio da un interesse autentico per l'umano, dalla curiosità, dall'attenzione vera.
Se io guardo voi non dico: "ecco quelli sono i miei studenti". Guardo per vedere come state e m'accorgo se uno ha gli occhi tristi o gli occhi allegri; ma non lo faccio perché sono "buona", lo faccio perché mi viene spontaneo, è un modo di guardare. Non saprò mai com'eri vestita oggi, se non perché ora lo sto dicendo, però mi rimane una traccia dello sguardo che avevi, della sensazione che m'hai dato oggi, di allegria, di confidenza. La creatività, secondo me, sta nell'essere aperti al nuovo; nel non vederti mai come t'ho visto l'ultima volta, non metterti in una mia casella, tra le cose che devo fare oggi, ma continuare a sorprendermi di tutte le cose nuove che posso vedere. Questo istintivamente, naturalmente, tranquillamente, porta (come sta succedendo tra noi adesso) verso un'apertura totale alla novità. Un po' come scriveva Kenny sul Natale: quando torni in famiglia e trovi che gli altri ti guardano sempre come quand'eri piccolo, con gli stessi schemi, ci resti male, ma poi scopri che tu fai esattamente la stessa cosa con loro. Creatività è evitare queste continue delusioni che ci procuriamo da soli. Purtroppo non riesce sempre, lo sappiamo bene, nelle relazioni e nel lavoro. Anche il lavoro con le persone, come quello dello psicologo può scadere nella routine.
Invece si può ancora inventare una nuova tecnica, un nuovo modo di risolvere un problema se non hai già in mente, per esempio, che con le persone depresse "si fa" una certa terapia! Se invece guardi, ascolti, accogli il rimando del suo sguardo e sei interessato a come ti risponde, allora va avanti da sé il rapporto terapeutico. Ma tutto questo richiede anche rigore e continuo controllo. Richiede "professionalità" .
Queste cose che mi dice mi fanno venire in mente una poesia di Masters, che apparentemente non c'entra nulla. Gliela leggo: